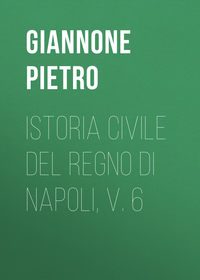Raamatut ei saa failina alla laadida, kuid seda saab lugeda meie rakenduses või veebis.
Loe raamatut: «Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6»
LIBRO VENTESIMOSECONDO
Morto re Carlo II nacque subito quella famosa quistione tra il zio ed il nipote sopra la successione del Regno; poichè dall'una parte il giovanetto Re d'Ungheria mandò Ambasciadori a Papa Clemente a dimandar l'investitura, non già come nipote, secondo l'error di Tiraquello1, ma come figliuolo di Carlo Martello primogenito del Re Carlo II. Dall'altra parte Roberto Duca di Calabria, ch'era allora col Papa in Avignone, diceva, che l'investitura doveasi a lui, come a figlio, e più prossimo in grado al Re morto. Fu con molte discussioni avute innanzi al Collegio de' Cardinali esaminato il punto: nel che importò molto al Duca di Calabria l'opera di Bartolommeo di Capua Dottore eccellentissimo, ed uomo, che per aver tenuto il primo luogo molt'anni nel Consiglio di Re Carlo, era divenuto per molta isperienza prudentissimo in pratiche di Stato. Costui trattò con molto valore la difesa del Duca, e tra le opere di Luca di Penna, e di Matteo d'Afflitto2 leggiamo le sue allegazioni ch'egli compose per questa causa. Scrisse ancora per Roberto, Niccolò Ruffolo valente Dottore di que' tempi, le cui allegazioni leggiamo impresse ne' volumi di Luca di Penna. E Gio. Vincenzo Ciarlanti3 vuole, che Roberto avesse seco condotto ad Avignone anche Andrea d'Isernia pur famoso Giureconsulto, perchè insieme col Capua prendesse la sua difesa. Chi sostenesse le parti di Caroberto non abbiam memoria; e se dobbiamo prestar fede a ciò, che di questa contesa ne scrisse Baldo Perugino4, non fu egli presso il Papa difeso, come ad una cotal difficile ed intrigata quistione si conveniva.
Ma ciò che sopra ogni altro rese al giudicio del Mondo, ed agli Scrittori giusta e prudente la decisione del Pontefice Clemente V a favor di Roberto, fu che Bartolommeo di Capua trattò questa causa non semplicemente da Dottore, ma dimostrò al Papa ed a' Cardinali, che oltre a quella ragione, che davano le leggi al Duca di Calabria, era necessario per l'utilità pubblica d'Italia, e del nome cristiano, che il Regno dovesse darsi a Roberto Signor savio ed espertissimo in pace ed in guerra, riputato un altro Salomone dell'età sua; e non più tosto al giovanetto Re, il quale senza conoscimento alcuno delle cose d'Italia nato, ed allevato in Ungheria, fra' costumi del tutto alieni dagl'Italiani, essendo costretto di governare il Regno per mezzo di Ministri e Baroni ungari, a niun modo avria potuto mantenerlo in pace, parendo ancora cosa non meno impossibile, che inconveniente, che il Duca di Calabria, il Principe di Taranto, ed il Principe d'Acaja zii del Re, e Signori nel Regno tanto potenti, avessero a star soggetti a' Baroni Ungari5; onde dopo molte discussioni, al fine fu sentenziato in favor di Roberto, ed al primo d'Agosto di quest'anno 1309 fu dichiarato in pubblico Concistoro Re di Sicilia ed erede degli altri Stati del Re Carlo suo padre; ed a' 26 del detto mese fu da Roberto in mano del Pontefice dato il giuramento di fedeltà e ligio omaggio, e ricevè dal medesimo l'investitura6 non meno di questo regno di Puglia, che di quello di Sicilia7; poichè i Pontefici romani, avendo per intrusi i Re Aragonesi, che possedevano la Sicilia senza ricercarne da essi investitura, per non pregiudicare le loro ragioni, investivano gli Angioini, così dell'uno, come dell'altro, secondo l'antico stile ed usitate formole. Questa investitura, oltre essere stata raccolta dal Chioccarelli nel primo tomo de' M. S. giurisdizionali, si legge tra le Scritture del regale Archivio8, ove fra i soliti patti e convenzioni, Roberto s'obbliga pagar ogni anno alla S. Sede nel dì di S. Pietro ottomila once d'oro per censo, in recognizione del Feudo: replicandosi ancora ciò, che nell'altre investiture era stabilito, che la città di Benevento restasse esclusa, e come fuori del Regno rimanesse per sempre in dominio utile e diretto della Chiesa romana. Così agli 8 di settembre nella città d'Avignone fu Roberto con tutte le solite cerimonie e con ogni pompa e celebrità incoronato Re9; ed il Papa a maggior dimostrazione di benevolenza, gli donò per autentica Bolla sottoscritta da tutto il Collegio, una gran somma di denari, che fu creduto passar trecentomila once d'oro, che dal Re Carlo suo padre e suo Avo, si doveano alla Chiesa romana per le spese fatte da Papa Bonifacio VIII, e suoi predecessori, nella spedizione di Sicilia10.
Essendo tutte queste cose trattate in Avignone nel Ponteficato di Clemente V, è gran meraviglia, come dai nostri Professori si creda Autore di tal sentenza il Pontefice Bonifacio VIII, che più anni prima era stato fatto prigioniere in Anagni da' Colonnesi, e morto in Roma per dolor d'animo. Nel che non è condonabile l'error di Tiraquello, e di alcuni altri11, che contro ciò che si legge in tutti i più gravi Storici12, scrissero, che Bonifacio avesse sentenziato a favor di Roberto, ingannato forse da ciò che si legge ne' Commentari di Baldo13, i quali secondo le edizioni vulgate, contenendo molte scorrezioni, sono stati cagione a lui ed agli altri di simili errori.
Fu tal sentenza commendata da Bartolo14, e quel ch'è più da Cino da Pistoia15, quel severissimo censore de' Pontefici e della Corte romana; e quantunque Baldo16 una volta la riprovasse, dicendo che in ciò il Papa fuit magis partialis, quam talis qualis esse debuerat: nulladimanco esaminando altrove17 la questione, e trovatala piena di difficoltà, e non così facile a determinare, tanto che fu costretto di dire, solvat Apollo, soggiunge, che avendo così determinato la Sede appostolica, esset ridiculum, et quasi haereticum disputare, quia injuriam facit judicio Reverendissimae Synodi, delle quali parole si valse anche il nostro Matteo d'Afflitto.
Fu ella poi, come rapporta anche Bzovio18, confermata da Benedetto XII, il quale avendo per mezzo de' suoi Legati ricevuto il giuramento di fedeltà e ligio omaggio da Roberto, gli confermò il Regno e ne lo investì con le medesime condizioni, che erano nell'investitura del Re Carlo I suo Avo19. Nè sono mancati Giureconsulti gravissimi, che l'han sostenuta con ragioni e con esempli, come Cujacio20, Ottomano21, Morisco, Mariana22, Arniseo23 e tanti altri. Quindi avvenne, che Roberto per mostrare che egli, perchè nato prima e come più prossimo in grado di Caroberto, dovea godere, ad esclusione di costui, della primogenitura, s'intitolava: Robertus primogenitus, etc. come assai a proposito avvertì anche Gio. Antonio de Nigris24 ne' suoi Commentarj.
Roberto adunque, favorito in tanti modi da Papa Clemente partì da Provenza per Italia, e quivi per mostrarsi grato al Pontefice, cavalcò per tutte le città, favoreggiando i Guelfi, e dichiarando, ch'egli sarebbe stato inimico a tutti coloro che cercassero d'infestare lo Stato ecclesiastico ed i partegiani suoi.
Giunse finalmente in Napoli, dove con pompa reale e con testimonio universale di gran contento il riceverono; poichè non solo ciascuna provincia del Regno, ma ogni Terra di qualche nome gli mandò Sindici a visitarlo e ad ossequiarlo: ed egli per mostrarsi meritevole del giudizio del Papa e della benivolenza de' Popoli, cavalcò per tutto il Regno riconoscendo i trattamenti de' Baroni e degli Ufficiali co' sudditi, con accarezzare quelli che si portavano bene; e per contrario riprese gl'ingiusti e tiranni, ordinando, che dovessero inviolabilmente osservare le leggi ed i Capitoli del Regno, che suo avo e padre aveano stabiliti. Tornato a Napoli, creò Duca di Calabria Carlo suo unigenito, ed onorò molti gran Baroni del titolo di Conte; e calcando le vestigia de' suoi maggiori, cominciò a far vie più bella e magnifica la città, non avendo ancor cagione alcuna di guerra. Diede in quest'anno 1310 principio al monastero di S. Chiara, luogo per Monache in ampio numero di quell'Ordine, con un separato Convento per molti Religiosi Conventuali, e piacquegli dichiarare questa magnifica chiesa, che fosse sua Cappella regia25. Fabbrica, che in magnificenza e grandezza non cede a niun altro edificio moderno d'Italia: ed è fama, che dal dì primo del suo Regno destinò tremila ducati il mese da spendersi, mentre e' vivea, prima in edificare la chiesa, e' Conventi, e poscia in comprare possessioni, de' cui frutti potessero vivere le Monache e' Frati. E vi è chi scrisse26, che Roberto per ammenda della morte proccurata a Carlo Martello suo fratello, affin di succedere al Regno, avesse usata tanta profusione in opera così pietosa; quasi che bastasse a cancellare tanta scelleraggine (se fosse vero il sospetto, che s'ebbe di lui) un tal edificio; e come se agli uomini per purgare i loro misfatti, bastasse il fabbricar chiese e monasterj, ed arricchirgli d'ampie rendite e possessioni. Scipione Ammirato27 ne' suoi Ritratti narra, essere stato ricevuto di mano in mano dalle memorie degli antichi in Napoli, che avendo Roberto condotta a fine la fabbrica di questa Chiesa, domandò al Duca di Calabria suo figliuolo quel che gliene paresse: a cui il Duca non per irreverenza, ma per non adular il padre, liberamente rispose, che gli parea, che fosse fatta a somiglianza d'una stalla. E ciò disse, perchè non avendo la chiesa ale, le piccole cappelle, che intorno son poste di mala grazia, che non continuano infino al tetto, rendono somiglianza di mangiatoje. Ma il Re, o come è natura di ciascuno, che senta con mal grado chi biasima le sue cose, o pur da divino spirito commosso: Piaccia a Dio, gli disse, o Figliuolo, che voi non siate il primo a mangiare in questa Stalla. E non è dubbio alcuno, il primo del Sangue Reale, che si seppellisse in S. Chiara, essere stato il Duca Carlo.
CAPITOLO I
L'Imperadore Errico VII collegato col Re di Sicilia nuove guerra al Re Roberto, e facendo risorgere l'antiche ragioni dell'Imperio, con sua sentenza lo priva del Regno; ma tosto lui morto, svanisce ogni impresa; e si rinova la guerra in Sicilia
Passò Roberto i primi tre anni del suo Regno in questi esercizj di pace; favorendo altresì, nel miglior modo che potea, la parte Guelfa per tutta l'Italia; ma furono questi studj di pace interrotti per la morte accaduta gli anni a dietro dell'Imperadore Alberto d'Austria; poichè essendo stato in suo luogo rifatto Re de' Romani Errico VII, il primo Imperadore dell'illustre Casa di Lucemburgo, e coronato in Aquisgrana, tutti i Ghibellini d'Italia mandarono a sollecitarlo, che venisse a coronarsi in Roma; e poichè lo Stato suo in Germania era di poca importanza, e bisognava con le ricchezze d'Italia sostenere il decoro imperiale, fu convocata una Dieta, ove furono tutti i Principi di Germania, nella quale fu conchiuso, che la Nazione alemana pagasse ad Errico un esercito, col quale potesse venire a coronarsi in Italia. Papa Clemente che ciò intese, dubitando, che per la sua residenza in Avignone non venisse ad occupare tutto lo Stato Ecclesiastico, ed a ponere la Sedia dell'Imperio a Roma, creò Conte di Romagna e Vicario Generale di tutto lo Stato della Chiesa Re Roberto, affinchè se gli opponesse. Mandò per tanto Roberto, sentendosi ch'Errico dovea calar in Italia, l'anno 1312 D. Luni di Raona con cento Cavalieri in ajuto dei Fiorentini, siccome fece ancor l'altro anno a Roma, mandandovi Giovanni Principe d'Acaja suo fratello con seicento Cavalieri catalani e pugliesi per contrastar la coronazione dell'Imperadore28.
Dall'altra parte Federico Re di Sicilia, che avea preso gran dispiacere, che 'l Regno di Puglia fosse rimasto a Roberto più tosto che al Re d'Ungheria, del quale per la distanza potea dubitar meno, e che avea pensato di battere in ogni occasione le forze del Re Roberto, pose molta speranza nella venuta dell'Imperadore, se bene nel principio non si discoverse. Ma offeso da Roberto per esser posto in acerbissima prigione (dove finì la sua vita) un suo Ministro, che avea mandato a Napoli a visitar Ferdinando figliuolo del Re di Majorica, fatto prigioniere in Grecia dal Principe di Taranto; da questa ingiuria pigliando occasione Federico non volle tardar più a scovrirsi; e giunto l'Imperadore in Italia, mandò Manfredi di Chiaramonte a visitarlo, ed a trattar lega con lui contra Re Roberto. L'Imperadore fe gran conto di quest'ambasciata e strinse la lega, e dichiarò Federico Ammiraglio dell'Imperio, e mandò a pregarlo, che con l'armata infestasse le marine del Regno, ch'egli presto sarebbe ad assalirlo per terra.
I Genovesi vedendo ora più gagliardo Errico per questa lega, lo riceverono come loro Signore, onde egli cominciò ad essere formidabile a tutta Italia; e giunto a Roma a' 29 di giugno di quest'anno 1312 fu con molta celebrità coronato in S. Gio. Laterano29; indi ripassato a Pisa, fece citar Roberto, come vassallo dell'Imperio, a comparir avanti di lui.
Gl'Imperadori d'Occidente, come s'è veduto nei precedenti libri di questa Istoria, pretendevano sovranità sopra questi Reami: l'investiture, come altrove fu detto, sono più antiche quelle degl'Imperadori d'Occidente che de' Romani Pontefici; onde è, che S. Bernardo, adulando l'Imperador Lotario, disse, che omnis, qui in Sicilia Regem se facit, contradicit Caesari; quindi, sempre che gli Imperadori ripigliavano forza in Italia, non tralasciavano quest'impresa. Errico cita Roberto, e questi non comparendo, lo dichiara contumace, indi a' 25 aprile del seguente anno 1313 fulmina contro lui la sentenza, colla quale lo sbandisce30, lo priva del Regno e di tutti i suoi dominii, e come ribello dell'Imperio lo condanna ad esser decapitato. Questa sentenza si legge presso noi nel primo tomo de' MS. giurisdizionali compilati per Chioccarello, e la rapporta anche Alberico ne' suoi Commentarii31.
(Questa sentenza è rapportata tutta intera da Lunig32; ma varia intorno al tempo della data, notandosi l'anno 1311. Rapporta eziandio alla pag. 1079 una lettera di Filippo Re di Francia scritta a Papa Clemente V, nella quale gl'incarica ad usar tutti gli sforzi per impedire gli attentati ed i progressi d'Errico contro Roberto suo parente, i quali potrebbero frastornar anche l'impresa di Terra Santa; onde Clemente fulminò una Bolla contro tutti i nemici del Re Roberto, dichiarandoli invasori del Regno, la quale si legge pag. 1086).
Nell'istesso tempo il Re Federico con potente armata infestava le Calabrie, e certamente le cose di Roberto sarebbero capitate male, se morte opportuna non l'avesse liberato; poichè mentre Errico se ne tornava in Toscana per quindi venire con gagliardo esercito a' danni del Re Roberto, per cammino cadde infermo, e arrivato a Buonconvento, castello del Contado di Siena, a' 24 agosto di quest'istesso anno 1313 se ne morì. Non mancano Scrittori che rapportano la sua morte essere stata proccurata da' Fiorentini, i quali avendo corrotto un Frate Domenicano nominato Pietro di Castelrinaldo, narrasi che questi gli dasse un'ostia attossicata nel tempo che gli richiese di voler prendere il Viatico.
(Il nome del Frate Domenicano che nell'Eucaristia attossicò l'Imperadore Errico VII non fu altrimente di Pietro di Castelrinaldo, ma di Bernardo di Montepulciano, e l'abbaglio d'alcuni Scrittori nacque d'aver confuso Frate Pietro, che presso il Re di Boemia Giovanni figlio d'Errico, prese la difesa di Frate Bernardo e del suo Ordine Domenicano, con Frate Bernardo imputato d'una tale scelleraggine nelle lettere apologetiche del Re Giovanni impresse dal Baluzio T. 1, Miscel., p. 162 si legge così: Nuper autem retulit nobis Religiosus Vir frater Petrus de Castro-Reginaldi, ordinis fratrum Praedicatorum, quod in magnum ipsius ordinis dedecus et contemptum facti sunt Romancii, Chronicae et Moteti, in quibus continetur, quod clarae memoriae Dominum et genitorem nostrum Imperatorem Henricum, Frater quidam Bernhardus de Montepeluciano, ordinis supra dicti, administrando ei Sacramentum Eucharistiae, venenavit; et propter hoc, ad defensionem veritatis, praedictus frater Petrus de Castro Reginaldi, habere super hoc litteram testimonialem humiliter supplicavit. E questo medesimo nome gli danno Tritemio Chron. Hirsaug. ad An. 1313 e Cuspiniano pag. 366. Parimente è da notarsi, che durando ancor a' tempi d'Errico VII il costume di darsi anche ai Laici la communione sub utraque specie, molti Scrittori antichi rapportano che il veleno non fu propinato nell'ostia, ma mescolato dentro il calice che se gli diede a bere: ed in questa maniera narra esser seguito l'avvelenamento Alberto Argent. pag. 118 dicendo: Dicebatur enim, quod ipse praedicator venenum sub ungue digiti tenens absconsum, post communionem potui Caesari immississet et illico discessisset. E lo stesso scrisse H. Stero ad A. 1313. Hic Imperator, ut communis fuit opinio, per penitentiarium suum, immixto veneno in Calice Domini, cum Imperator ab ipso Eucharistiam sumeret, extinctus fuit, et Pisis sepultus. Veggasi Martino Disembachio, il quale compilò una particolar dissertazione, de vero mortis genere, quo Henricus VII. obiit. Dove nel §. 39 sulla fede di Tritemio Cron. Hirsaug. ad Annum 1313 rapporta, che a que' tempi fu così comune e costante la credenza che Errico fosse stato avvelenato da un Frate Domenicano, che per questo misfatto fosse stata imposta pena a tutto l'ordine de' Predicatori, che i loro Monachi non potessero comunicare se non colla mano sinistra coloro, che s'accostavano all'altare. Veggasi parimente Burcardo Struvio Syntag. Hist. Germanor. Dissert. 25, §. 15, il quale rapporta le arti e gli sforzi che fecero i Domenicani presso Giovanni Re di Boemia, per purgarsi di questa imputazione; e la propensione di quel Re di favorirli, così perchè temeva che non gli concitassero l'odio del Clero, come anche perchè de' medesimi valevasi per Confessori e Consultori di sua coscienza, rapportando eziandio i sospetti che s'aveano, non quelle lettere apologetiche trascritte da Baluzio, fossero false o almanco estorte da Giovanni per loro importunità ed artificj).
Altri lo niegano, e dicono essersi ammalato per contagion d'aria e morto di febbre33. Checchè ne sia, la morte d'Errico pose in tanta confusione i Capi del suo esercito ed il Re Federico che, ciascuno tolse la sua via, e Federico mesto si ritornò in Sicilia; ma essendo il Re Roberto fieramente con lui adirato, il qual rotta la pace, che avea seco, s'era scoperto in su quella venuta amico dell'Imperadore; fatta un'armata di cento venti galee tra quelle di Provenza, del Regno e de' Genovesi, andò egli stesso in persona con Giovanni e Filippo suoi fratelli a danni di quell'isola. E furono i principj molto lieti, perciò ch'egli prese per forza Castello a mare, e posto l'assedio a Trapani, ebbe grande speranza d'averla; ma ingannato da' terrazzani che l'aveano tenuto in parole di concerto con Federico, l'indugio fu tale che vedendosi mancata la vettovaglia, ed andar tuttavia infermando il suo esercito, nè volere il Re Federico venire seco a battaglia, nè in mare, nè in terra, fu costretto far tregua co' Siciliani per tre anni, e tornossene il primo giorno dell'anno 1315 a Napoli molto peggiorato.
Fra questo mezzo Papa Clemente V, morto Errico, avendo ripreso vigore il suo partito, cavò fuori una sua Bolla, colla quale rivocò, ed annullò la sentenza fatta dall'Imperadore contro Roberto. Questa oggi la leggiamo tra l'altre decretali de' romani Pontefici, avendola i Compilatori del dritto Canonico inserita fra le Clementine34, e si legge ancora nel primo volume dei MS. giurisdizionali del Chioccarelli.
Re Roberto convenendogli portarsi ora in Provenza, ora nell'impresa di Sicilia, sovente in Fiorenza, in Genova ed altrove, avea costituito Vicario del Regno, secondo il costume de' suoi maggiori, Carlo Duca di Calabria suo figliuolo, di cui perciò, come si disse, abbiamo molti Capitoli, fatti da lui mentr'era Vicario in assenza di suo padre. Ma Roberto non avendo altri figliuoli, pensò di casarlo e conchiuse il matrimonio con la figliuola dell'Arciduca d'Austria, onde mandò in Alemagna il Conte Camerlingo, e l'Arcivescovo di Capua Ambasciadori con onoratissima compagnia di Nobiltà. Costei ebbe nome Caterina, la quale condotta con grandissimo onore a Napoli, fu poco fortunata, perchè dopo non molto tempo morì senza lasciar figliuoli; tanto che da poi Re Roberto diede a Carlo la seconda moglie che fu Maria figliuola di Carlo Conte di Valois, della quale ebbe tre figliuole, come diremo più innanzi.
Intanto essendo finito il tempo della triegua co' Siciliani, il Re Roberto deliberò seguire l'impresa di Sicilia, ed avendo posto in acqua un buon numero di navi, afflisse tanto quell'isola, e le forze del Re Federico, che fu comune opinione che se Roberto avesse continuata la guerra in quel modo, avrebbe certamente ricoverato quel Regno; ma i Siciliani, essendo morto nel mese di aprile dell'anno 1314 Clemente V e rifatto in suo luogo Gio. XXII mandarono subito una imbasciata de' maggiori uomini dell'isola a rallegrarsi della creazione, ed a pregarlo, volesse trattare la pace o la triegua fra que' due Principi. Il nuovo Papa mandò perciò un Legato al Re Roberto, che lo indusse a far nuova triegua per cinque altri anni.